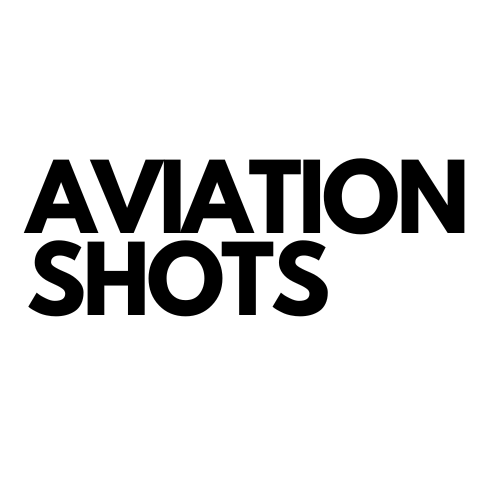TIGER MOTH "I-GATO"
Salire su una macchina del tempo e librarsi in volo con la leggerezza di una falena e l'agilità di una tigre. Questo e molto altro ho provato realizzando il sogno di volare a bordo del Tiger Moth più vecchio presente d’Italia, quello di Giancarlo Zanardo.
“So soltanto che voglio questo biplano. Lo voglio perché voglio viaggiare attraverso il tempo e voglio pilotare un aereo difficile e sentire il vento mentre volo, e che la gente guardi, veda, sappia che la gloria esiste ancora. Voglio esser parte di qualcosa di grande e di magnifico”.
Se riconoscete queste parole è perché avete letto il libro “Biplano” di Richard Bach, il noto autore del best seller “Il gabbiano Jonathan Livingston”. Può sembrare un inizio un po’ scontato quando si scrive un articolo che parla di un biplano, ma non ho trovato parole migliori, perché è allo stesso modo, con parole molto simili, con la stessa emozione e con la luce negli occhi, che Giancarlo Zanardo mi ha parlato del suo Tiger Moth.
Premessa
Era da tanto tempo che desideravo volare come si volava una volta, con la testa fuori, con il vento in faccia, con il rumore dell’aria e del motore nelle orecchie, e di farlo possibilmente su un biplano, su un aereo storico originale, vecchio ma con uno spirito ancora giovane, con un temperamento ancora intatto.
Lo scorso 6 ottobre ero presente all’evento “Nulla-Via-Invia – Progetto, costruzione e voli del Caproni Ca.3R I-ZANA” e decisi di raccogliere tutto il materiale possibile per scrivere un report su come è nato e come vola il Caproni Ca.3 Replica. L’articolo è uscito sul numero di Novembre 2024 di VRF Aviation, così decisi di informare Giancarlo Zanardo della pubblicazione, concludendo la mia e-mail con questa frase: “Sono un pilota e amo gli aerei storici, ma non ho mai avuto l’opportunità di volare su un biplano. Mi piacerebbe molto fare un volo sul suo Tiger Moth, anche un volo di pochi minuti: sarebbe possibile?”. Giancarlo è stato molto entusiasta dell’articolo sul Caproni Ca.3, giudicandolo corposo e ben fatto, ed ha terminato la sua e-mail di risposta con questa frase: “Per il volo sul Tiger Moth venga quando vuole”.
Nel leggere queste ultime parole ho provato una gioia incontenibile, difficilmente descrivibile; composi subito il numero di telefono di Giancarlo e concordammo di incontrarci per il volo il sabato successivo.
Sulle ali del tempo
Il 16 novembre 2024 la giornata era splendida. L’appuntamento con Zanardo è per le 10:30 presso il campo di Nervesa della Battaglia, ma alle 10 sono già al cancello e vengo accolto calorosamente da Roberto Tomadini, P.R. addetto alle relazioni esterne della “Fondazione Jonathan Collection”. Giancarlo arriva poco dopo, io mi presento, ci salutiamo, e subito ci dirigiamo insieme verso l’hangar “Gianni Caproni”, a pochi passi di distanza.
Iniziamo col dire che questo non è un hangar qualsiasi: si tratta di un Bessoneau Type H, uno dei più tipici esempi di architettura aeroportuale dei primordi dell’aviazione e probabilmente l’unico esemplare originale al mondo ancora utilizzato per scopi aeronautici. È riconosciuto come bene di interesse storico-culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Bessonneau è un hangar modulare, trasportabile, costituito da capriate e piedritti in legno e rivestimento in tela, con vari tipi di montanti esterni di controventatura. La struttura poteva essere montata in 48 ore da una squadra di 60 persone. Il progetto è del francese Julien Bessonneau (1842-1916) e la prima installazione documentata risale al 1912, sul campo di Etampes. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale il Bessonneau divenne uno degli hangar più utilizzati dai paesi dell’Intesa. L’uso del Bessoneau in Italia è attestato a partire almeno dal 1916. La sua modularità consentiva di montarlo e smontarlo nel giro di due giorni, perciò veniva spostato insieme al fronte e, se il fronte indietreggiava, veniva bruciato per non farlo cadere in mano al nemico. Quello che si trova al campo Jonathan è stato acquistato in Inghilterra nel 2010, trasportato in Italia con due autoarticolati, restaurato e rimontato; il rivestimento in tela, ormai vecchio e inutilizzabile, è stato sostituito con uno moderno.
Nel varcare la soglia dell’hangar si fa un salto all’indietro di più di 100 anni. Giancarlo mi racconta brevemente la storia di ciascun aereo. Sul lato sinistro troviamo lo Spad XIII R, il Fokker Dr.1 R ed il Fokker Eindecker R. Sul lato destro c’è il DH.82A Tiger Moth, l’SE.5A R ed il Sopwith Camel R. In fondo all’hangar è stato ricavato uno spazio ad uso officina dove, tra l’altro, c’è un Boeing Stearman in fase di restauro.
Nel frattempo Daniele Beltrame, collaboratore tecnico della Jonathan Collection e co-pilota del Caproni Ca.3, porta fuori dall’hangar il Tiger Moth e comincia ad eseguire i controlli pre-volo. Giancarlo avrebbe voluto portarmi in volo personalmente, ma a causa di un forte mal di schiena, ha incaricato Daniele a farmi da pilota. Mi aiuta comunque ad indossare il caschetto di pelle e gli occhialoni (eh sì, proprio come si usava allora, fatta salva una modifica per l’installazione dell’interfono), poi mi dà indicazioni su come salire nel posto anteriore, quello riservato all’allievo pilota e posto sul baricentro dell’aereo. Mi sistemo sul sedile e Daniele mi aiuta ad indossare le cinture a quattro punti, ancora rigorosamente originali, e ad agganciarle al dispositivo di fissaggio. Il Tiger Moth ha due piccoli sportellini che si aprono verso il basso della fusoliera per consentire un più agevole accesso ai sedili. Decidiamo di tenere aperti i miei sportellini durante il volo per agevolarmi nelle riprese fotografiche. Con l’aereo bloccato nell’avanzamento dagli appositi “tacchi fermaruote” e con me sistemato nell’abitacolo, Daniele inizia la procedura di accensione del motore che, vista la mancanza del motorino di avviamento, avviene a forza di braccia facendo fare all’elica dei mezzi giri, stando attenti di non rimetterci le mani quando il motore decide di partire! Dopo qualche tentativo andato a vuoto, il Gipsy Major III da 130 cavalli prende vita e vengo investito dal flusso dell’aria generato dall’elica, provando una prima nuova sensazione.
Daniele sale al suo posto dietro di me, si allaccia le cinture e facciamo una prova dell’interfono. Via i tacchi, rulliamo al punto attesa per pista 33 e attendiamo che l’olio motore vada in temperatura. In rullaggio, come un po’ per tutti gli aeroplani biciclo, il muso è alto e la visibilità anteriore è praticamente nulla. Chiamata all’aria e ci allineiamo in pista; tutto motore ed iniziamo la corsa di decollo; la coda si alza quasi subito e la visibilità in avanti migliora, anche se di poco; dopo circa 150-200 metri raggiungiamo la velocità di 90 km/h e stacchiamo l’ombra da terra! Proseguiamo la salita mantenendo i 100 km/h e seguendo il letto del fiume Piave in direzione Nord-Ovest.
E siamo già immersi nella storia! Il Piave, infatti, dopo Caporetto, è divenuto il “fiume sacro alla Patria” ed il campo Jonathan si trova esattamente nei luoghi in cui nel giugno 1918 i soldati italiani fermarono l’ultima offensiva austriaca.
Livelliamo alla quota di circa 1000 ft e ci mettiamo in crociera a 120 km/h. Non posso sapere esattamente a che quota stiamo volando, perché sul cruscotto ho soltanto due strumenti: un indicatore di velocità ed uno sbandometro basico, la famosa “pallina”. Giancarlo mi ha spiegato che per volare sul Tiger Moth non serve nient’altro, e che lo strumento più importante è proprio la “pallina”. L’aereo è difficile da pilotare. Non è come un aereo moderno dove i comandi rispondono subito. Muovendo solo la cloche non succede niente; soltanto un movimento perfettamente coordinato e deciso tra cloche e pedali consente di virare!
La visibilità anteriore anche in volo è scarsa; bisogna sporgersi in fuori e guardare il fianco della fusoliera per vedere quello che si ha davanti. Nelle altre direzioni però, la posizione con la “testa fuori” consente di vedere tutto, sia di lato, che sopra e sotto. Il flusso dell’aria si sente, ma non è fastidioso, sempre se si resta con la testa al centro dell’abitacolo, senza sporgersi. Daniele mi dice che vola meglio con il passeggero a bordo, perché quando c’è solo il pilota il posto davanti vuoto crea un vortice d’aria poco piacevole.
In ogni caso l’emozione che si prova a non essere chiusi in una cabina, a non avere niente tra te e il cielo, è semplicemente fantastica. Ho steso la mano ed ho toccato il cielo con le dita. La sensazione è di libertà è totale. Puoi respirare la libertà!
Viriamo a destra e ci dirigiamo a Est fino a raggiungere il paese di Susegana. Qui si trova il Castello di San Salvatore risalente al XII secolo, emblema inconfondibile del panorama trevigiano, cinto dalle dolci colline del Prosecco come in un abbraccio. Proseguiamo verso Sud in direzione di Colfosco e poi verso Est fino a sorvolare il Sacrario Militare del Montello, che è uno dei principali ossari della Prima Guerra Mondiale e raccoglie le spoglie di 9.325 soldati italiani caduti sul fronte del Piave. Ma in questo volo vogliamo rendere omaggio anche all’Asso degli Assi Francesco Baracca, e lo facciamo effettuando un paio di giri intorno alle pendici del Montello, dove si trova il Sacello costruito nel luogo esatto in cui furono ritrovati i resti del velivolo ed il corpo di Baracca. A sottolineare l’importanza storica della zona che stiamo sorvolando, nel raggio di un chilometro sono ben cinque i monumenti dedicati a caduti del Piave.
Lasciando il Montello facciamo rotta verso Nord per ritornare al campo. Stendo le braccia fuori dall’abitacolo e per qualche istante il Tiger Moth diventa un triplano! Voglio sentire il vento sulle mani, sulla faccia. Siamo alla metà di novembre, ma non sento freddo. Percepisco il rumore del motore, forte, e anche quello dell’aria. Parlarsi nell’interfono non è facile: bisogna avvicinare moltissimo il microfono alla bocca e coprirlo bene con la mano prima di parlare, e anche così si sente poco e male. Siamo di nuovo sul Piave e lo seguiamo fino al campo di volo. Arriviamo per un passaggio basso sulla pista, molto basso; effettuiamo due giri intorno agli hangar e poi una bella cabrata per riprendere un po’ di quota e portarci in sottovento sinistro per pista 15 (la preferenziale per gli atterraggi); anche il sottovento si fa sorvolando il letto del fiume; poi viriamo in base e quindi in finale. Io non ho mai volato prima su un biciclo, perciò mi fa un po’ impressione non poter vedere davanti all’aereo durante il corto finale e la flare. La velocità di approccio è di 100 km/h e ad un paio di metri da terra Daniele toglie motore e completa l’atterraggio. E’ passata circa mezz’ora dal decollo. Il tempo è volato!
Rulliamo sul prato diretti alla pompa del carburante. Ci fermiamo, Daniele scende ed inizia a fare il pieno. Io non mi muovo. Tocco l’aereo, la cloche, gli strumenti del cockpit, la manetta, le cinture ed il dispositivo di sgancio. Respiro. Sento l’odore dell’aeroplano. L’odore del tempo. Non mi decido a scendere. Voglio essere sicuro che non sia tutto un sogno. Sorrido. Mi giro e noto che Giancarlo mi sta osservando. Anche lui sorride. Nel suo sorriso si rispecchia tutta la mia emozione. Ci siamo capiti. Non servono le parole.
La storia del Tiger Moth I-GATO raccontata da Giancarlo Zanardo
Terminato il volo chiedo a Giancarlo di parlarmi di come è nata la sua passione per i biplani in generale e di quella per il suo Tiger Moth in particolare. Questo il suo racconto.
La storia del Tiger Moth nasce perché da sempre, fin da bambino, ho desiderato volare con un biplano, che rappresenta per me un periodo pionieristico, e quindi anche l’epoca più romantica del volo. Perciò negli anni Sessanta, poco più che ventenne, decido di prendere il brevetto di volo. La mia esperienza inizia però con gli autogiro negli anni tra il 1964 ed il 1968, perlopiù autocostruiti. Nel 1970 dopo un volo nella zona di Bibione a bordo di un autogiro idro, ho avuto un brutto incidente mentre caricavo il mezzo sul carrellino, perché per un problema tecnico il paranco si è staccato e mi ha colpito violentemente alla testa. Nel periodo passato in ospedale ero andato in crisi depressiva grave perché non mi sentivo più capace di fare niente, non riuscivo a stare in equilibrio, a stare in piedi, e non ci sentivo più dall’orecchio sinistro. Pensavo a chissà quale lavoro avrei potuto fare in queste condizioni, a come sarebbe stata la mia vita futura. Quindi dovevo trovare un qualche cosa che mi stimolasse a tornare a vivere. Ed ho pensato alla mia passione per il volo, promettendomi di ritornare a volare non appena fossi stato meglio, e che lo avrei fatto con un biplano. Ho impiegato due anni per riprendermi; ho fatto la visita medica e mi hanno consentito di volare con l’istruttore; facevo la visita ogni tre mesi, poi ogni sei mesi, finché non ho ottenuto un rinnovo pieno e la possibilità di volare anche da solo. Il mio orecchio sinistro è rimasto però irrimediabilmente danneggiato con la conseguente perdita dell’udito da questo lato.
In quel periodo, casualmente, un amico mi ha parlato di un Tiger Moth in vendita presso l’Aeroclub di Vergiate; al suo proprietario non avevano rinnovato la visita medica e non poteva più volare. Contatto quindi il proprietario dicendogli che sono interessato all’aeroplano e chiedo quando costa. Il prezzo richiesto era di 5.500.000 lire. Sono andato immediatamente a Vergiate in ufficio dal proprietario per dargli i soldi prima che cambiasse idea e poi sono andato a vedere l’aeroplano. Era il 1976.
Inizio quindi a fare avanti e indietro da casa mia a Vergiate per fare il passaggio macchina sul Tiger Moth, perché avevo poca esperienza con gli aeroplani, visto che avevo fatto il brevetto nel 1966 ma poi ero rimasto in stand-by. Dopo alcuni voli con l’istruttore, ho portato da solo l’aeroplano da Vergiate a Belluno, dove sono rimasto fino al 1985, anno del trasferimento presso l’Aeroclub di Treviso, del quale ero diventato Presidente. Sempre nel 1985 mi contatta l’amico Fausto Gubian, uno storico dell’aviazione, che voleva fare qualcosa di speciale per festeggiare il 75° anniversario della prima scuola di aviazione civile italiana, fondata il 10 agosto 1910 presso La Comina in provincia di Pordenone. Si decide di fare un giro d’Italia, isole comprese, per commemorare questo evento e portare alle scuole di volo un messaggio promozionale scritto per l’occasione dall’allora presidente dell’AeCi Guido Baranca. Sono quindi partito da La Comina in solitario con il mio Tiger Moth ed ho volato per 5.000 chilometri allo scopo di promuovere il volo in tutta Italia. Le tappe principali sono state Pescara, Bari, Palermo, Roma, Cagliari, Albenga, Trento. L’intero giro l’ho effettuato con bussola, cronometro e sempre due cartine, perché una può volare via visto l’abitacolo aperto. Al termine sono atterrato a La Comina dove ho trovato una calorosa accoglienza ed ho preso parte ad una bellissima cerimonia.
Sempre nel 1985, al ritorno dal raid, ho fondato l’aviosuperficie ‘Campo Jonathan’ a Cimadolmo in provincia di Treviso, dove sono rimasto dieci anni prima di spostarmi a Nervesa della Battaglia nell’attuale campo dedicato a Francesco Baracca, perché proprio in questa zona l’Asso degli Assi dell’Aviazione Italiana ha fatto il suo ultimo volo prima di essere colpito a morte e precipitare a 2 km in linea d’aria da qui.
In seguito ho fatto parecchie attività sempre volando con il Tiger Moth. Nel 1987 ho effettuato un raid Italia-Inghilterra di 3.500 km insieme ad altri 9 velivoli storici per partecipare all’Airshow Tiger Club di Redhill. Nel 1989 ho preso parte con il Tiger Moth ad un altro raid Italia-Inghilterra in gruppo con 10 velivoli storici, ma poi ho attraversato della Manica a bordo del mio velivolo autocostruito Blériot XI-2 per celebrare l’80° anniversario della storica impresa compiuta da Louis Blériot nel 1909. In questa occasione il Tiger Moth, pilotato dall’amico Rino Prizzon, ha scortato il Blériot XI durante l’attraversata da Calais a Manston.
In Italia ho partecipato ad innumerevoli airshow, spesso in coppia con il triplano Fokker Dr.I del Barone Rosso, con il quale ingaggiavo degli spettacolari ‘dogfight’.
Nella mia vita ho fatto circa 3.000 ore di volo sul Tiger Moth. Visto il pesante utilizzo nel corso delle manifestazioni aeree, durante le quali si è quasi sempre a pieni giri, la revisione del motore la faccio ogni 500-600 ore di volo. Due volte l’ho fatta in Inghilterra, mentre le altre volte in Italia presso aziende specializzate e ordinando i pezzi di ricambio nel Regno Unito.
Da qualche anno a questa parte ho ridotto di molto l’attività di volo con il Tiger Moth; intervengo solo su richiesta per partecipare prevalentemente a degli eventi o commemorazioni importanti.
Questo DH.82A è stato il primo aereo della Jonathan Collection ed è il più vecchio Tiger Moth volante in Italia. È stato costruito nel 1941 dalla Morris Motors con numero di costruzione 85253. Fino al 1953 è stato utilizzato dalla RAF con matricola DE193 presso le scuole di volo di Peterbrough, Wolverhampton, Fairoaks e Digby, nonché presso il London University Air Squadron. E’ stato ceduto sul mercato civile nel 1953 e acquistato nel 1959 dall’Aero Club Vicenza che lo immatricolò I-GATO. Passò poi all’Aeroclub di Vergiate nel 1967 e poi acquistato da me nel 1976. Il motore è ancora quello originale e così pure la cellula, anche se nel tempo quest’ultima ha subito alcune piccole modifiche, quali ad esempio l’installazione dei freni a disco sulle ruote del carrello principale (meno belli da vedere, ma più efficaci), al posto di quelli a tamburo dei quali non si trovavano più i ricambi. Nel corso degli anni il Tiger Moth ha subito due incidenti gravi, fortunatamente causando danni soltanto all’aeroplano e non ai piloti.
La prima volta è stato a causa di un atterraggio di emergenza in seguito allo spegnimento del motore, al termine del quale l’aeroplano si è capovolto. Ci sono voluti quattro anni di lavoro per ripararlo; ho voluto fare io la riparazione, ma è stato molto complicato perché l’aeroplano non era una costruzione amatoriale e quindi aveva un normale certificato di navigabilità; ho quindi dovuto dimostrare che ero in grado di ripararlo da solo senza ricorrere ad aziende specializzate.
Il secondo incidente grave è successo il 3 marzo 2015 durante il primo volo di collaudo del Caproni Ca.3. Io stavo rientrando al campo a bordo del Caproni in seguito all’emergenza per lo spegnimento di uno dei tre motori, mentre Rino Prizzon ci scortava in volo a bordo del Tiger Moth. Rino, preoccupatissimo per quello che stava succedendo, mi seguiva sulla destra alla distanza di circa 100 metri e, mentre il Caproni era in atterraggio, Rino, tutto intento a guardarmi, non ha visto l’unico albero che c’era a bordo pista, prendendolo in pieno! Un disastro! Il Tiger Moth ha subito danni gravissimi, ma per fortuna Rino ed il fotografo Paolo Franzini che era a bordo non si sono fatti niente. Per la riparazione ho avuto la fortuna di trovare a Forlì un Tiger Moth danneggiato da un incendio, dal quale ho recuperato il castello motore, il carrello e altri pezzi della cellula. Le ali sono state ricostruite integralmente, l’elica sostituita ed il motore originale revisionato e reinstallato; il resto dell’aeroplano è stato reintelato ed ora è come nuovo!
Oltre ad essere stato protagonista di imprese memorabili e ad aver partecipato a numerosissimi eventi e manifestazioni aeree, il Tiger Moth è stato utilizzato per le riprese di spot pubblicitari, documentari, film (come ad esempio ‘Noi eravamo’ di Leonardo Tiberi) e, non ultima nel 2023, la fiction della Rai sulla vita di Francesco Baracca. Nel 1996 mi era stato chiesto di partecipare alle riprese del film ‘Il paziente inglese’, ma ho rifiutato perché avrei dovuto fare un lungo trasferimento sul mare, ed io ho il terrore di volare sul mare. L’alternativa era quella di smontare l’aeroplano e fare la traversata su una nave, ma non avevo voglia di smontarlo e quindi ho rinunciato.
Conclusione
Terminata l’intervista siamo andati a pranzo. Seduto alla destra di Giancarlo l’ho ascoltato raccontare le imprese aviatorie che ha compiuto nella sua vita, con i vari aneddoti, i momenti belli e quelli brutti, le soddisfazioni e gli incidenti. E quando parlava del Tiger Moth, di tutto quello che ha vissuto con questo aereo, i suoi occhi brillavano come quelli di un innamorato. Ora capisco cosa questo aereo significa per lui e perché Giancarlo faccia volare soltanto chi ritiene in grado di apprezzare questo tipo di volo su questo tipo di aeroplano, avendo la consapevolezza del privilegio che questo comporta. Grazie Giancarlo.
P.S. Perché I-GATO? Il Tiger Moth di Zanardo, prima di passare all’Aeroclub Vergiate, fu acquistato nel 1959 dall’Aero Club Vicenza. Varie leggende del ‘400 e del ‘700 hanno portato a definire i vicentini come mangiatori di gatti, da cui il detto “Vicentini magna gati”. Proprio per questo rapporto particolare tra Vicenza ed il felino, l’Aeroclub ha pensato allora di immatricolare il Tiger Moth come I-GATO.
De Havilland DH.82 ‘Tiger Moth’ – Informazioni generali
Il ‘Tiger Moth’ è uno dei più celebri aerei di tutti i tempi, utilizzato per l’addestramento fino al 1959 dalla Royal Air Force britannica e da quelle delle sue colonie. Caratterizzato da carrello fisso e abitacolo biposto in tandem, fu progettato da Geoffrey De Havilland quale evoluzione per addestramento militare del DH.60, dal quale differiva per la fusoliera in tubi metallici (anziché in legno) e le ali a freccia (anziché diritte). Il prototipo, propulso da un motore Gipsy III da 120 CV, volò il 26 ottobre 1931. La versione definitiva DH.82A montava il Gipsy Major III, un 4 cilindri in linea invertito da 6,124 litri e 130 CV, e fu costruita in 5.760 esemplari. La produzione complessiva fu di 8.611 unità, dei quali 2.903 su licenza in Canada, Australia e altri paesi. Avendo formato decine di migliaia di piloti presso 38 aeronautiche militari del mondo, dopo la Seconda Guerra Mondiale trovò una seconda giovinezza presso aero club e privati. Nel 2009 ne esistevano ancora più di mille. In Italia, dove non ebbe mai uso militare, ne sono presenti alcuni esemplari importati a partire dal 1958.
Lunghezza: 7,43 mt
Apertura alare: 8,94 mt
Altezza: 2,68 mt
Superfice alare: 22,2 mq
Peso a vuoto: 506 kg
Peso massimo al decollo: 828 kg
Velocità massima: 175 km/h a 2.200 giri
Velocità di crociera: 120 – 130 km/h a 1900 – 2000 giri
Velocità di rotazione: 90 km/h
Velocità di salita ottimale: 100 km/h
Corsa di decollo: 150 mt
Velocità in atterraggio: 100 km/h
Velocità di stallo: 75 km/h
Tangenza: 4145 mt
Autonomia: 480 km
Capacità serbatoio: 82 litri
Consumo medio: 32 litri/ora